Uno degli aspetti più interessanti (e spesso anche divertenti) dei vari forum e gruppi di homebrewer è il momento in cui un neofita chiede consigli sulle prime ricette che ha creato da solo. Vengo immediatamente catapultato ai tempi delle mie prime ricette, anch’esse piene di incongruenze ed errori grossolani.
A volte non si tratta di veri e propri “errori”, ma di un approccio che non afferra appieno l’articolazione del processo produttivo e la complessità organolettica e strutturale dei singoli ingredienti.

La ricerca ossessionante della complessità
Le prime volte che ci si trova davanti al foglio bianco nel momento di creare una ricetta, si prova una forte sensazione di spaesamento. Con tutti quegli ingredienti a disposizione, limitarsi nell’utilizzo appare riduttivo. Produrre una American Pale Ale con una base composta al 100% da solo malto Pale sembra quasi un insulto ai produttori di malto. Se esistono così tante tipologie differenti di malto, perché dovrei utilizzarne uno soltanto? Come faccio a ottenere quelle sfumature biscottate, leggermente mielose con un morbido tocco di crosta di pane e nocciola sul finale?
Devo per forza utilizzare tre o quattro malti diversi, magari facendomi aiutare dai nomi. Cerco il biscotto? Uso il Biscuit. Voglio sentire il miele? Aggiungo un po’ di Honey Malt. Voglio potenziare l’aroma? Uso l’Aromatic. Sono alla ricerca dei composti dati dalla reazione di Maillard? Aggiungo il Melanoidin. E via dicendo. Alla fine esce fuori una ricetta con cinque tipi di malto differenti, ognuno in percentuali che nemmeno un cane da tartufo sarebbe in grado di percepire. Insieme creano un intruglio aromatico indistinto, spento, senza alcuna vitalità. Un po’ come mia figlia piccola quando mischia tutti i colori del Didò dando vita a un unico informe pezzo gigante di colore verde militare. Poi non lo usa più e ne vuole uno nuovo, ovviamente. Ed è quello che più o meno succede con le birre prodotte utilizzando questa filosofia che potremmo definire della “complessità forzata”.
Poi scopri che una birra complessa come la Saison Dupont è fatta con 100% malto pils, così come lo sono molte altre birre che tutto sembrano fuorché banali. Perché non è che i malti base siano insapore, o monodimensionali. Il malto d’orzo è comunque un ingrediente complesso che già da solo presenta decine di sfumature aromatiche. Non stiamo parlando del mais o del riso, per dire. Semplificare è la parola d’ordine, specialmente se si è agli inizi. Aggiungere è più semplice che togliere, perché capire quali dei 18 malti aggiunti in ricetta non funziona in un mappazzone aromatico di birra è molto più complicato che partire da una base aromatica semplice e aggiungere sfumature nelle successive produzioni. Una ricetta è come un disegno pieno di colori: si procede per aggiunta man mano che si procede con l’opera, non si butta tutto a caso sul foglio per rifare poi il disegno da capo usando meno colori.

Il braccino corto con il luppolo
Produrre birre luppolate in casa è difficile. Lo è sempre stato, ma il mercato ci ha ormai abituato a degli standard talmente alti da indurre forti crisi depressive anche negli homebrewer più capaci. Tuttavia, se proprio si vuole provare a brassare una IPA in casa, magari un clone di qualche birra che ci piace particolarmente, bisogna usare il luppolo. E bisogna usarne tanto. Eppure vedo continuamente ricette di IPA e APA che in alcuni casi nemmeno prevedono il dry hopping, o lo prevedono in quantità ridicole per una IPA (nell’ordine dei due grammi litro).
Purtroppo le birre luppolate, specialmente se ispirate a stili americani, si fanno con il luppolo. C’è poco da girarci intorno. Per avere dei macro livelli di riferimento, parliamo di dosaggi nell’ordine di 3-6 g/L negli ultimi minuti di bollitura (i litri in questo caso sono quelli a fine bollitura) e 3-6 g/L per il dry hopping (litri di birra nel fermentatore). Per le APA ci si posiziona nella parte bassa del range, per le IPA in quella alta. Molte interpretazioni moderne e modaiole vanno anche oltre, ma in questo caso occorre seguire approcci diversi, soprattutto in dry hopping, per non arrivare alla saturazione degli oli disciolti nella birra.
Per fare un esempio generico, la quantità di luppolo che si utilizza mediamente in una produzione da 20 litri di IPA ruota intorno ai 150-250 grammi (contando solo i luppoli in late boil e dry hopping). Datevi una regolata e allungate quel braccino, mi raccomando.

Le birre watery
Oltre che per la fantomatica ricerca della complessità, molti homebrewer aggiungono malti speciali alla ricetta per aumentare la densità finale della birra (Final Gravity, detta anche FG). Magari inizialmente si parte da una buona idea, tipo una base maltata semplice con malto Pale affiancato da uno spruzzo di Vienna; poi però, una volta aggiunto il lievito, si scopre che il software prevede una FG di 1,008 e arriva il panico totale. Oddio, la mia birra sarà watery, non avrà corpo, farà schifo! Presi dall’ansia, iniziamo a spostare la temperatura di ammostamento sempre più in alto aggiungendo contestualmente malti a caso in ricetta per “dare corpo”.
Ed ecco che entrano in scena il Carapils, i fiocchi di qualsiasi cosa, i malti destrinici o anche i crystal in percentuali esagerate per uno stile che magari dovrebbe essere il più semplice possibile. Tutto questo solo per alzare di 3 punti la FG e sentirsi a posto con la coscienza, come se qualche grammo di residuo zuccherino in più potesse salvare la birra. Ovviamente non è così, ma soprattutto alcuni stili di birra sono watery per definizione perché sono pensati per bevute seriali. Che poi il termine “watery” non ha e non deve avere una accezione necessariamente negativa: può essere una caratteristica dello stile, spesso è un aspetto importante che contraddistingue le cosiddette “birre da bancone”.
Ma se la FG non è l’unica variabile che influenza il corpo, quali sono le altre? Sono molte, variegate, spesso interdipendenti tra loro. Difficile isolare i singoli fattori, ma possiamo lanciare qualche spunto.
Prima di tutto il luppolo: oltre agli oli essenziali, da cui derivano le sue caratteristiche aromatiche, i luppoli rilasciano polifenoli. Questi, oltre all’astringenza se presenti in dosi eccessive, aumentano la percezione del corpo (si pensi al vino rosso e ai suoi tannini). Nel sidro alcuni consigliano addirittura di aggiungere tannini in polvere (link) proprio per sostenere il corpo. Per questa ragione non si deve aver paura che una session IPA venga fuori con poco corpo se ha una bassa FG: la luppolatura pesante (che deve esserci per forza) aiuta in questo senso, anche grazie all’intenso flavour che genera.
Come ben sappiamo, il malto non si esprime solo in termini di zuccheri fermentabili (altrimenti useremmo zucchero da tavola nelle ricette). I cereali contribuiscono con proteine, tannini, beta glucani e altri carboidrati vari che il lievito non riesce a fermentare. Soprattutto, il malto porta aromi e sapori. Nelle bitter, l’utilizzo di malti crystal arricchisce il profilo organolettico con aromi di toffee, caramello, pane bruciato, leggero dattero e molti altri. Anche se il contributo al corpo non è significativo dal punto di vista della FG e degli zuccheri complessi aggiunti, l’aroma e il flavour portano la nostra mente a percepire un corpo maggiore, una birra più complessa e meno watery.
Potremmo andare avanti (ad esempio citando il glicerolo rilasciato dal lievito nelle saison) ma ci fermiamo qui.

Ammostamento con step a caso
Premetto che io non ho mai fatto un doppio step di saccarificazione nei miei 7 anni di produzione, quindi potrei essere leggermente di parte. Qualche volta passo per un veloce protein rest, ma per il resto i miei ammostamenti sono rigorosamente all’inglese e prevedono una singola pausa di saccarificazione a una determinata temperatura. Lo faccio più per ragioni pratiche che per principio: avendo un sistema automatico che tiene bene la temperatura ma non gestisce altrettanto bene le rampe, preferisco tenere tutto stabile per non dover passare tempo davanti al pentolone invece di sanificare, iniziare a pulire o semplicemente rilassarmi.
Detto ciò, quando si progettano gli step di saccarificazione si deve capire bene cosa si sta facendo e non farli per moda o perché ci si sente poco fighi a non farli. La motivazione alla base degli step multipli di saccarificazione è fondamentalmente una: sfruttare l’attività delle beta amilasi a bassa temperatura (intorno ai 63°) per produrre zuccheri molto fermentabili e bloccarla in un preciso istante facendo salire la temperatura nella parte estrema del range. In questo secondo step agiscono in solitaria le alfa amilasi che terminano la conversione trasformando i pochi amidi residui (se ce ne sono) in destrine. Più tempo si passa nel primo step, maggiore la fermentabilità del mosto. Il secondo step in molti casi si fa per un tempo molto breve (anche di 15 minuti) solo per assicurarsi di non lasciare amidi residui. Il primo step dura di più perché le beta amilasi lavorano più lentamente. Queste sono più o meno le dinamiche.
Detto ciò: come faccio a capire quando finire il primo step e iniziare il secondo?
È proprio qui che risiede la difficoltà, perché non esiste un modo veloce per misurare la tipologia di zuccheri disciolti nel mosto. Il test dello iodio ci dice se ci sono ancora amidi, ma non ci dice quanti sono né quale tipologia di altri zuccheri è presente nel mosto. Misurare la densità con il rifrattometro può dare un’indicazione di massima, ma siamo nel regno dell’approssimazione. La verità è che serve esperienza. Si fa una birra con determinati step, si fermenta, si valuta quello che succede. Si produce di nuovo la stessa ricetta, magari cambiando leggermente temperature e tempi dei due step, si fermenta, si valuta nuovamente il risultato. Difficile? Certo. Ma proprio per questo chi è alle prime armi farebbe bene a stare lontano dagli step. Io ve l’ho detto.

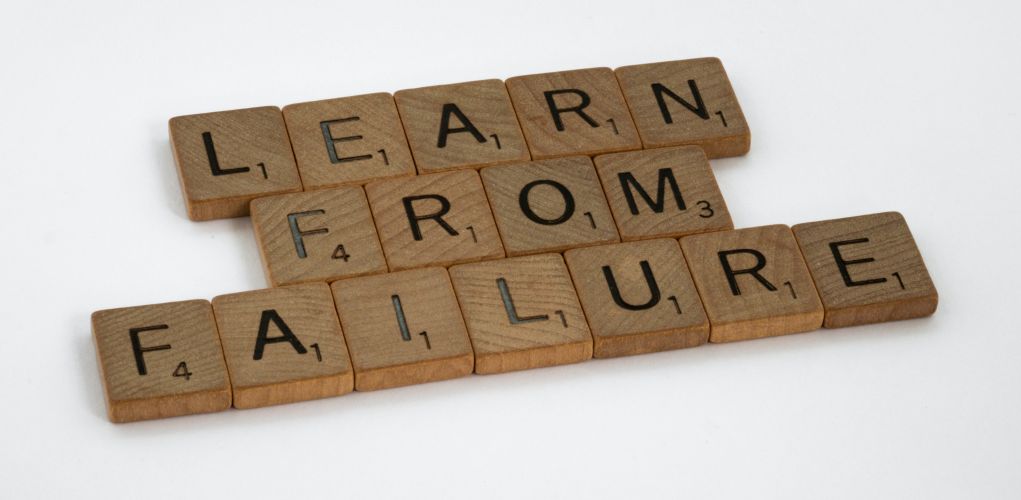


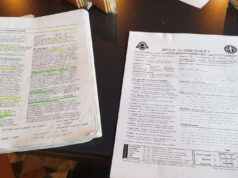
Parole sante Frank, parole sante.
Ti quoto praticamente su tutto.
Su alcune sottigliezze non condivido al 100%, ma se parliamo di chi e alle prime armi allora sono d’accordo con te.
Anch’io prediligo il single step, oddio a differenza tua sono uno che esegue spesso (non sempre però) protein rest, ma molte io ho obbiettivi diversi dai tuoi a volte, ne abbiamo già discusso, e quello step esula comunque da tuo discorso…almeno per me.
Solo in casi molto particolari uso un secondo step, mi viene in mente mia triple, su cui eseguo un mash davvero molto basso, ed in genere faccio un secondo step molto alto prima del mash out (non usando io sacca della biancheria 😉 ) a conversione quasi ultimata, ma e solo per terminare (o meglio aver la certezza di aver terminato) conversione degli amidi il più possibile (stabilità).
Ma se non erro e unico caso a memoria in cui effettuo un secondo step.
Dunque la penso come te.
Fantastico esempio del didò di tua figlia…un esempio che mi ha fatto sorridere per la sua semplicità, ma che e molto calzante…ma vallo a spiegarlo, a volte e un lavoraccio…e lascio perdere.
Mia prima birra fu 100% pils.
Su fg vs watery sono concorde….seppur con qualche distinguo, nel senso che quello che dici e corretto, ma in caso di ricette collaudate, o collaudate ma da ritoccare, fg può assumere un valore di assoluta rilevanza (non parlo del punto in più o in meno in se ovviamente), io il carapils lo uso a volte per andare di quel poco oltre le soglie a me possibili del mash, solo per fare uno stupido esempio, però in fg se presa così e relativa, molto relativa, ho assaggiato birre con og che dire basse e poco…ma godibilissime e con un loro bilanciamento assolutamente perfetto.
E questione di struttura complessiva.
Come dico spesso la birra, quando si produce, quando si progetta, non va vista solo in due dimensioni…le dimensioni sono molteplici. 🙂
Ma vallo a spiegare…poi il tempo, se la passione regge, farà lui da insegnante comunque. 😉
Scusa, scrivo da lavoro, e scrivo a pezzi tra un cliente e un’altro…ed e un po’ un disastro il tutto.
In ogni caso “ho assaggiato birre con og che dire basse e poco” in realtà mi riferivo ad fg….non ad og ovviamente….torno a lavorare che e meglio. 🙂
Eh, sì: avevo intuito! 🙂
Eh…e che sono abituato su forum, che posso correggere poi con calma.
E dunque praticamente non rileggo mai ciò che scrivo, tanto son sempre di fretta e scrivo a pezzi come detto prima, tanto poi correggo dopo…ma qua non posso…come ho scoperto…ahahahah
Va beh dai….pace amen.
Ciao Frank,
sono quello che domenica ha lasciato i grani in infusione fino a 95°! Questi tuoi articoli e il tuo approccio mi infondono sempre molta tranquillità. Aspettiamo il libro con ansia
Meno male, mi fa molto piacere!
Mi presento,sono un novellino con quattro cotte alle splalle ag, e tanta voglia di imparare.Ho sempre letto con interesse e ammirazione quello che scrivi,fino ad oggi.Questo atteggiamento altezzoso che hai nei confronti di tutti i ragazzi che hanno meno esperienza di te mi ha spiazzato!pensavo di trovare qualche spunto da questo articolo..non di sentirmi denigrato.Mi spiace che nel mondo dell homebrewer ci siano persone così. Demigrat
Riccardo, mi spiace se hai considerato l’articolo “altezzoso”. Voleva essere ironico, visto che sono errori che tante volte anche io ho commesso (e, incredibile, a volte li faccio ancora, magari per la fretta). Non volevo in alcun modo essere irrispettoso, ma questo blog di tanto in tanto è volutamente scorretto, altrimenti non si chiamerebbe brewing bad ma “facciamo tutti birra insieme appassionatamente”. Faccio ancora tanti sbagli anche io, figurati. Ma cerco di riderci su.