La maturazione della birra è un processo complesso che gioca sugli equilibri evolutivi di diversi composti. Aromi e sensazioni evolvono nel tempo, modificando l’espressione aromatica e il profilo gustativo.
Non tutte le birre migliorano con la maturazione. Sicuramente cambiano, ma non sempre in meglio.
In questa serie di articoli proveremo a capire cosa accade ai principali composti nella birra durante la maturazione, con l’obiettivo di gestire al meglio il processo di maturazione (detto anche aging in inglese).
Vedremo anche quali sono le differenze tra una maturazione al freddo (lagerizzazione) e una maturazione a temperatura di cantina. E gli effetti – principalmente negativi – di una conservazione a temperatura troppo alta.
In questa prima puntata ci occuperemo dell’evoluzione di esteri, alcoli e fenoli.
Esteri fruttati
Gli esteri si formano durante la fermentazione per effetto di una serie di reazioni catalizzate dagli enzimi della famiglia delle transferasi (enzimi AAT, ovvero Alcohol AcylTransferase), partendo da un acido e da un alcol. Questi enzimi sono sintetizzati dal lievito.
Durante la fermentazione è attiva anche un’altra classe di enzimi, le esterasi, che catalizzano invece la scissione degli esteri in alcol e acido. Il bilanciamento tra queste due azioni contrastanti durante la fermentazione determina la quantità di esteri presenti nella birra.
Gli esteri, in particolare gli esteri acetati (ovvero formati tramite combinazione con l’acido acetico), tendono a ridursi con il tempo (link). Sebbene alcuni suggeriscano che questo avvenga per effetto degli enzimi esterasi citati sopra, raramente è così, poiché durante l’invecchiamento il lievito non è più attivo e gli enzimi non catalizzano alcuna reazione.
È molo più probabile invece che, con il tempo, gli esteri semplicemente si idrolizzino nella birra (che è un ambiente acido), dividendosi in alcol e acido. Di conseguenza, la birra tende con il tempo a perdere gli aromi fruttati.
Esteri come l’acetato di etile (aroma di pera/fruttato, solvente in alte concentrazioni) o l’acetato di isoamile (aroma di banana) tendono a ridursi con il passare del tempo. Quanto tempo? Non poco, specialmente se le concentrazioni di partenza sono alte. Una birra con forte aroma di solvente difficilmente tornerà a posto prima che altri effetti negativi dell’invecchiamento prendano il sopravvento.
L’idrolisi in ambiente acido procede lentamente quando non è catalizzata da alcun enzima (le esterasi, attive durante la fermentazione).
Parliamo di parecchi mesi di conservazione a temperatura ambiente (20–25 °C) o al caldo (>30 °C). Al freddo, tutto ciò avviene molto più lentamente.

La riduzione degli esteri con il tempo tende a far emergere altri aromi, in parte anche dovuti all’invecchiamento. Nel libro Vintage Beers, Patrick Dawson afferma che gli esteri fruttati, con il tempo, virano verso note di frutta matura. Questo, a mio avviso, può essere dovuto alla comparsa di note ossidative (spesso dovute ad aldeidi) che, combinate con il residuo di esteri, producono aromi che ricordano la frutta matura.
Gli esteri tendono quindi a ridursi con la maturazione, a velocità maggiore se questa avviene a temperatura ambiente o al caldo. La riduzione degli esteri prodotti durante la fermentazione, insieme alle altre reazioni legate all’invecchiamento, può far emergere aromi che ricordano la frutta matura.
Alcoli superiori
L’alcol maggiormente presente nella birra è l’etanolo (alcol etilico). La sua concentrazione dipende dalla quantità iniziale di zuccheri presenti nel mosto e dall’attenuazione del lievito. L’etanolo non si ammorbidisce né si riduce significativamente durante la maturazione della birra.
Ovviamente, la concentrazione dell’etanolo aumenta se durante la maturazione vengono fermentati altri zuccheri. Ma questo, in genere, non dovrebbe accadere.
L’etanolo non è però l’unico alcol presente nella birra. Esistono altri alcoli prodotti dal lievito durante la fermentazione, chiamati alcoli superiori. Questi derivano dal percorso metabolico del lievito che sintetizza gli aminoacidi necessari per la crescita cellulare.
Gli aminoacidi vengono continuamente “smontati” e “rimontati” dal lievito per assemblare proteine ed enzimi. Lo scarto di questo processo metabolico (chiamato percorso di Ehlrich) produce alcoli con più di due atomi di carbonio, detti appunto alcoli superiori o fusel alcohols.
La produzione degli alcoli superiori non è legata direttamente alla concentrazione iniziale di zuccheri nel mosto, ma principalmente alla moltiplicazione cellulare e ai nutrienti disponibili.
Una parte di questi alcoli, durante la fermentazione, viene trasformata in esteri fruttati. Ad esempio, l’acetato di isoamile si forma dall’unione di acido acetico e alcol isoamilico (che è un alcol superiore con cinque atomi di carbonio).
Gli alcoli superiori sono determinanti per la complessità del profilo organolettico della birra, sia come alcoli (che contribuiscono direttamente all’aroma) sia quando si combinano con acidi per formare gli esteri.

Gli alcoli superiori possono aumentare la sensazione di “warming” al palato apportata dall’etanolo, facendola diventare fastidiosa. Fortunatamente, questa sensazione tende ad affievolirsi con il tempo.
È però improbabile che gli alcoli superiori vengano esterificati durante la maturazione, per la stessa ragione già citata parlando di esteri: il lievito non è più attivo e nemmeno le transferasi che catalizzano la reazione di esterificazione.
È invece più probabile che gli alcoli superiori si ossidino durante l’invecchiamento, formando aldeidi fruttate. In parte, questo può accadere anche all’etanolo, che può trasformarsi in acetaldeide in presenza di quantità significative di ossigeno, ma è meno probabile. Le aldeidi derivanti dall’ossidazione degli alcoli superiori possono ricordare aromi di frutta rossa, vini fortificati, sherry e madera.
Curiosamente, questo tipo di ossidazione non richiede necessariamente ossigeno disciolto: può essere scatenata da composti già ossidati nella fase di produzione del mosto. È stato osservato che queste ossidazioni sono più frequenti in mosti ricchi di melanoidine, quindi in birre ambrate o più scure (link).
La maturazione tende quindi ad arrotondare il “warming” alcolico, ma può generare nuovi aromi fruttati che risultano piacevoli in alcune birre, meno in altre.
Fenoli speziati
Dei fenoli presenti nella birra ho già parlato in modo approfondito in un post di qualche tempo fa (link). I principali fenoli volatili e aromatici che possiamo trovare nella birra sono quattro (in figura) e derivano dagli acidi idrossicinnamici presenti nel mosto, che a loro volta provengono dai malti.

Nella maggior parte dei casi questi fenoli aromatici vengono prodotti dai lieviti POF+ durante la fermentazione, ma possono anche derivare da lunghe bolliture, da bruciature del mosto o dall’utilizzo di malti affumicati. In questo ultimo caso, l’aroma ricorda principalmente l’affumicato (e grazie al ca).
Come evolvono gli aromi fenolici nel corso dell’invecchiamento della birra?
Questo articolo ci dice che il 4VG (4-vinil-guaiacolo), ovvero l’aroma che spesso viene percepito come chiodo di garofano, tende a idrolizzarsi nel tempo, trasformandosi in vanillina, che è un’aldeide fenolica. Il processo è di tipo ossidativo ed è accelerato dalla presenza di ossigeno nella bottiglia. Questa è la principale ragione per cui le Weissbier, con il tempo, tendono a perdere l’aroma di chiodo di garofano che le caratterizza, virando verso note più dolciastre e vanigliate (link).
Alcuni suggeriscono che un altro aroma fenolico, il 4-vinil-siringolo (4VS), possa essere associato all’invecchiamento della birra (link), ma non è chiaro come si formerebbe senza l’azione del lievito. Dovrebbe avere un aroma di leggero affumicato che può ricordare anche il tabacco.

Prime conclusioni
Nel prossimo post approfondiremo l’effetto dell’invecchiamento sull’amaro, sul dolce e sull’astringenza. Da questa prima carrellata possiamo però già intuire quanto sia delicata la gestione della maturazione in una birra.
Gli esteri tendono a ridursi, così come i fenoli. Il bilanciamento tra queste due componenti aromatiche, fruttata e speziata, può variare sensibilmente durante la maturazione, fino a snaturare completamente il profilo organolettico della birra.
Nel frattempo gli alcoli superiori si ammorbidiscono, trasformandosi in aldeidi che aggiungono ulteriori componenti dolciastre, con aromi che virano verso la frutta rossa o i vini fortificati.
Gestire la progressione di queste reazioni a nostro vantaggio, per migliorare il profilo organolettico della birra, non è affatto semplice, richiede esperienza e attenzione. Vedremo che la temperatura a cui avviene la maturazione può avere un impatto significativo sulle dinamiche di invecchiamento.
Stay tuned (qui il post successivo).




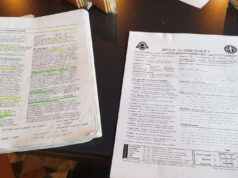
Bravo Frank, nell’idea questa serie di articoli.