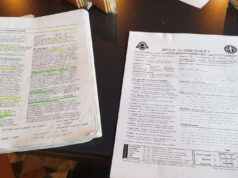Nel post precedente abbiamo visto come esteri, fenoli e alcoli evolvono durante la maturazione. Il quadro è già abbastanza complicato, oggi lo complicheremo ancora di più.
Cercheremo di capire come il bilanciamento tra dolce e amaro cambi nella birra durante l’invecchiamento. I meccanismi chimici alla base di queste evoluzioni sono complessi e per molti aspetti non ancora del tutto chiari. Almeno, non lo sono per me.
Vedremo anche che aspettare all’infinito che una birra diventi più buona di quanto lo fosse alla fine della fermentazione può essere controproducente. L’aroma di “vecchio” ci aspetta in agguato: attendere non sempre porta benefici.
Dolcezza
Con la maturazione e l’invecchiamento, qualsiasi birra tende a sviluppare aromi che suggeriscono sfumature dolci come miele, caramello, toffee ma anche note di sherry, vini fortificati, madera.
Molti di questi composti dall’aroma dolciastro derivano dallo sviluppo di carbonili che si legano in aldeidi come la benzaldeide (aroma di mandorla), il b-demascenone (aroma di frutta rossa) o altre aldeidi (come le aldeidi di strecker) con aromi di miele.
Anche l’ossidazione degli alcoli superiori può sviluppare aldeidi fruttate con aromi di madera o sherry. Alcuni sostengono che questi aromi fruttati possono derivare da esteri che si formano durante l’invecchiamento, anche in assenza di fermentazione attiva. Probabilmente l’effetto fruttato è il risultato della combinazione dei due fenomeni.
La presenza di ossigeno molecolare (ossigeno disciolto) può accelerare le reazioni di ossidazione che portano alla formazione composti aromatici dall’aroma dolciastro, ma la loro comparsa può essere anche effetto di degradazioni non legate all’ossidazione o di perdita di elettroni (che viene sempre chiamata ossidazione) senza che sia necessariamente l’ossigeno a scatenarne la migrazione da una molecola all’altra.
Insomma, è tutto molto complicato.
Al di là dei fenomeni chimici di dettaglio, molti dei quali sono tuttora oggetto di studio, possiamo dire con certezza che la dolcezza nella birra, durante la maturazione, tende ad incrementare con il tempo. Questo è dovuto sia alla comparsa di nuovi composti aromatici che suggeriscono dolcezza, sia all’effettivo livello dell’amaro che tende a ridursi con il passare del tempo.

Amaro
La principale causa del sapore amaro nella birra sono gli alfa acidi isomerizzati. Si formano durante la bollitura della birra a partire dagli α-acidi presenti nel luppolo. Il calore della bollitura cambia la configurazione spaziale della molecola di α-acido, creando quello che viene chiamato un isomero.
Gli alfa acidi isomerizzati (iso-α-acidi) conservano la formula chimica degli α-acidi ma hanno proprietà diverse: sono maggiormente solubili in acqua e più amari al palato. Con il passare del tempo, gli iso-α-acidi tendono a cedere elettroni ad altri composti presenti della birra, ossidandosi.
Queste reazioni di ossidazione (perdita di elettroni) possono avvenire sia per interazione con l’ossigeno (più precisamente con i ROS, radicali liberi derivati dall’ossigeno), sia per interazioni con altri composti in grado di attirare elettroni. Gli iso-α-acidi possono quindi ossidarsi e perdere il loro potere amaricante sia in presenza che in assenza di ossigeno molecolare.
La degradazione degli alfa acidi nel tempo porta a una progressiva riduzione dell’amaro percepito nella birra. Possiamo quindi concludere che l’amaro si riduce con la maturazione.
Per mia esperienza, in birre piuttosto alcoliche (come, ad esempio, un Barleywine o una Imperial Stout), la riduzione dell’amaro è piuttosto lenta. Questo può essere dovuto all’effetto antiossidante di alcol e malti scuri, ma la mia impressione generale è che la riduzione dell’amaro procede molto più lentamente di altre reazioni legate all’invecchiamento e alla maturazione.
Non mi aspetterei miracoli nella riduzione dell’amaro in un Barleywine nel giro di qualche mese di maturazione. Ho abbandonato l’approccio “aumento gli IBU perché lo farò maturare a lungo”. Nella mia esperienza personale, l’amaro percepito in birre molto alcoliche è sempre rimasto piuttosto stabile nel primo anno di maturazione (poi non lo so, perché raramente le lascio maturare di più).
In birre meno alcoliche e chiare, dove l’effetto antiossidante di malti scuri e alcol è minore, la degradazione dell’amaro può essere più veloce.
A volte subentrano altri fattori come l’aumento di composti che danno una impressione di dolcezza (i carbonili di cui abbiamo parlato prima), che possono alterare la percezione dell’amaro anche a parità di IBU. Questo è un aspetto da tenere in considerazione.

Il sentore di “vecchio”
L’ossidazione ha una molteplicità di effetti sul profilo organolettico della birra. Alcuni – seppur in misura ridotta – possono essere positivi, ma nella maggior parte dei casi il risultato è una diminuzione della qualità sensoriale.
Non essendo dovuta unicamente all’ossigeno disciolto, l’ossidazione (che altro non è che uno scambio di elettroni) può manifestarsi anche in birre prodotte e imbottigliate con la massima attenzione e con le tecnologie più avanzate. È inevitabile che, prima o poi, la nostra birra inizi a degradarsi per via della migrazione di elettroni da una molecola all’altra.
Agli effetti dell’ossidazione ho dedicato una serie di post (che partono da qui), ma oggi voglio soffermarmi sul composto che più frequentemente viene misurato per capire – a livello quantitativo – quanto velocemente la birra stia invecchiando, e quanto lo stia facendo male.
Parlo di lui: il trans-2-nonenale.
Il trans-2-nonenale (che è una aldeide) è uno dei principali responsabili del difetto di cartone bagnato. Si forma a partire dagli acidi grassi insaturi, che in genere derivano dai malti (in particolare dall’acido linoleico).
La sua formazione inizia già nella fase di produzione a caldo, quando il mosto entra in contatto con l’aria, e prosegue in una lunga serie di reazioni che degradano i lipidi in aldeidi a lunga catena, tra cui appunto il trans-2-nonenale. Questo può accadere – e spesso accade – anche in assenza di ossigeno disciolto in bottiglia.
La formazione del T2N è piuttosto inevitabile proprio perché non dipende direttamente dall’ossidazione a freddo. Il processo inizia quando il mosto caldo entra in contatto con l’ossigeno, specialmente a temperature in cui è ancora attivo l’enzima lipossidasi, che accelera le reazioni di ossidazione degli acidi grassi (sotto i 60°C, in zona protein rest: un altro buon motivo per saltare questo inutile passaggio).
Per rallentare la catena di reazioni che porta al rilascio di quantità significative di T2N è fondamentale mantenere la birra al freddo. Qui entrano in gioco i delicati equilibri legati alla temperatura di maturazione, che dobbiamo gestire al meglio per favorire alcune reazioni – come la riduzione degli alcoli superiori – e rallentarne altre, come il rilascio del T2N. Ma di questo parleremo nel prossimo post.

Riassumendo
Il puzzle della maturazione si complica. Credo stia iniziando a diventare chiaro quanto sia difficile, nella pratica, gestire tutti i meccanismi che si nascondono dietro l’invecchiamento della birra quando l’obiettivo è raggiungere il picco del profilo organolettico.
Le sensazioni dolci aumentano con la maturazione, l’amaro si riduce. Esiste un momento in cui questi due percorsi si incontrano in un equilibrio perfetto. Il tutto deve però accadere prima che emergano gli effetti negativi della maturazione, come ad esempio la comparsa degli aromi di cartone bagnato.
Risulta evidente come non possa esistere una formula magica per prevedere quanto a lungo una birra debba maturare. Nel prossimo post (link) parleremo degli strumenti che abbiamo a disposizione per guidare al meglio il processo di invecchiamento.